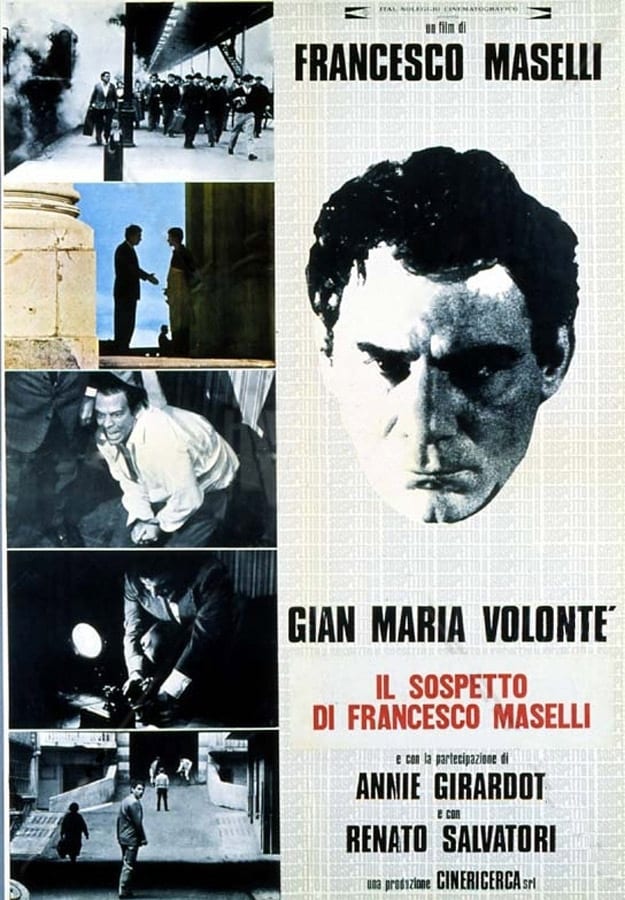Ognuno ha la sua etica e il giornalismo non ne ha nessuna. Non enuncio nulla di nuovo, parlo di fatti personali. Io a pranzo/cena/letto con attori/attrici non ci sono mai voluto andare. E nemmeno a intervistarli, che di solito implica qualcuna delle suddette cose. Un critico non deve, o almeno non dovrebbe. Il concetto è quello – ridotto all\’osso – di una mia \’celebre\’ lettera ai Duellanti: . Ma si può estendere finché vi pare. Dal piano ammezzato della mia notorietà professionale ho provato imbarazzo nel dover porre domande a casaccio a Elio Germano (di cui pure ero entusiasta), a Keira Knightley (che certo mi dimenticò un attimo dopo che lasciai la sua suite) e persino a Julie Andrews (che invece si invaghì del mio profumo e dei miei ricordi: se proprio devo fare un\’intervista mi piace arrivarci preparato: archivio fitto e fragranza Hermes). Non puoi andare lì, chiedere, interessarti e poi stroncare (e nemmeno gradire). Sei contaminato, infetto, fai un altro lavoro: il giornalista appunto, che sta al critico – che pure è una brutta parola – come il cuoco di manicaretti sta al palato competente che se li ingozza.
Sono cose separate, a prescindere. Ti esponi a orridi rischi di riprovazione (che possiamo anche considerare giusta). L\’ho vista negli occhi di attori e registi dei quali avevo detto fin troppo chiaro ciò che pensavo, quando poi li incontravo alle conferenze stampa: luoghi/eventi che mai un critico dovrebbe frequentare, figuriamoci a tu per tu. Quindi ho evitato il più possibile e quando non ho potuto evitare ho perso il posto (di intervistatore e conseguentemente di critico), oppure mi sono limitato a lodi dette come schermaglie (ad esempio con Paolo Sorrentino) che credo sia il giusto taglio di dialogo che debba intercorrere tra un Uomo che Guarda e l\’oggetto del suo lavoro.
Non voglio fare il martire, non mi è costato niente (a parte qualche stipendiuccio). Limitarmi alla critica mi ha anzi evitato quel gran rifrullamento di aria fritta e coglioneria che sono appunto le interviste, prima ancora che l\’imbarazzo di cui ho appena parlato. Gli \’altri\’ la pensano quasi tutti diversamente: intervistano, presentano, scrivono biografie e poi giudicano – inutile dire come – l\’oggetto del loro affanno scribacchino. E\’ normale, si è pagati a pezzo.
C\’era un solo regista con cui non ho potuto fare a meno di cenare: Emidio Greco. Me lo \’portò\’ il mio amico Franco Cordelli dritto in trattoria, nel grembo di un gruppo di intellettuali che si incontra ogni domenica sera a Ponte Milvio e che spesso mi ha fatto l\’onore di addentare con loro bistecche (pessime) e concetti (intriganti). In un\’altra occasione si andò a vedere una partita a casa di Andrea Cortellessa: Milan-Lazio. Emidio mi sembra di ricordare simpatizzasse per i biancoazzuri, squadra che da sempre vedo con occhio benevolo; in ogni caso quella sera giocava col Milan (che ovviamente vinse) e non c\’era discussione. Ci furono invece molte discussioni dopo, su svariati argomenti, e rimase tra noi un filo di simpatia e di ammirazione (lo dico con vergogna: più sua verso di me che mia nei suoi confronti: avevo visto solo due dei suoi film, sebbene uno – “Una storia semplice” – mi avesse incantato). L\’altro era “Ehrengard” che mi precipitai a rivedere subito dopo e trovai sublime.
Ci incontrammo altre volte, affettuosamente. E la stima crebbe, reciproca. Al punto che cominciai a peccare. Per fortuna Emidio Greco girò pochi film, ma per quattro volte io me li trovai di fronte. E dunque che fare? Come giudichi liberamente l\’opera di un amico quando non ne conosci solo il prodotto finale, ma la passione che vi sta dietro, l\’accanita ricerca di finanziamenti, il sogno decennale di portare sullo schermo proprio quel racconto?
“Il consiglio d\’Egitto” e “L\’uomo privato” non mi piacquero e non li recensii. “Milonga” non lo capii e cercai di spiegare perché (un mancamento mi prese quando seppi che lui in primis voleva capire perché io non capissi). “Notizie dagli scavi” è un piccolo capolavoro che ho avuto l\’onore di recensire con la giusta rilevanza su un importante quotidiano nazionale per il quale poi non scrissi oltre.
Ora Emidio è morto, togliendomi da un imbarazzo che adesso più che mai mi sembra degno e giusto. Ora che io stesso – con modalità più terrene – mi ritengo morto alla critica. Siamo entrambi più liberi. E\’ un peccato non poter parlare adesso di idee, finanziamenti, Lucentini e Sciascia.
Anche sulla notizia della sua dipartita, dopo una malattia troppo breve perché ne giungesse notizia su fino a Milano, sono arrivato da pessimo giornalista: in ritardo. Ci ha pensato Franco a infilare il mio nome nel necrologio, come un piccolo scasso nella memoria dell\’unico regista che diceva in giro che \’mi voleva bene\’. I registi non doverebbero volere bene ai (loro) critici; i critici devono girare al largo dai registi.
E\’ stato un (mio) peccato. Oggi un peccato in ogni senso.
E\’ stata eccezione che conferma la mia regola, e sono contento che sia stato per Emidio.
Sono a Milano, da solo, mezzanotte passata. Sto camminando sotto i portici di via Hoepli. Vengo da qualche cinema e vado verso qualche mezzo di trasporto con cui tornare a casa. Non ricordo i particolari intorno, ma la sensazione dentro, quella sì. Ho paura.
Ho appena visto Una storia semplice. In pochi minuti – lo so – il malessere diverrà inquietudine, tensione, sgarbato prurito d’insicurezza: tutti brividi sensati considerando che indotti ‘solo’ dall’aver assistito ad un film e che l’età del ‘vietato ai minori’ è passata da un decennio. Ma adesso ho paura. Quella che ti fa affrettare il passo, temere i passanti, sbirciare in anticipo dietro le colonne. Quella (sarà la vetrina illuminata della libreria?) che ho provato l’ultima volta dopo L’uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento. Angoscia, spiazzamento, piccolo (ma crescente) panico da sovvertimento della percezione.
Cosa accomunava, nei miei ingranaggi mentali, una (tutt’altro che semplice) storia siciliana di doppi giochi, impegno civile frustrato e perenni, interminabili giorni della civetta, al debutto, ancora più profondamente giallo che rosso, di un regista che si sarebbe perso nella deriva dell’effettaccio visivo? Quel finale da ko sul ring delle emozioni, è chiaro. E non parlo dell’identificazione di un ‘colpevole’, roba da giallo classico, espediente che sorprende ma non intimorisce affatto; mi riferisco al ‘colpo di memoria’ che coglie i protagonisti dei due film in un finale che – in entrambi i casi – è già un finale-bis, un finale-post, un agguato al dispiegarsi degli eventi su binari sui quali eravamo indotti (noi complici attenti ma sereni) a seguirli. Un finale che ribalta ogni prospettiva, sconvolge la pellicola, ne ridisegna le luci e le ombre, priva lo spettatore della confortante coperta della prevedibilità. Ora, se questo è logico in un thriller di Argento, giunge del tutto inatteso, e quindi doppiamente spiazzante, in un film posato (per quanto teso) come quello di Emidio Greco. Da qui lo smarrimento di sé e subito la paura. Che avverto ancora – la stessa – rivivendo il momento. Ancora sento quella sensazione di pericolo imminente e di mancanza di punti di riferimento rassicuranti che mi colse sotto il colonnato, in cerca di una nicchia (nel cervello, nell’architettura, non importa) per rimettere insieme i cocci della razionalità.
Solo in seguito ho letto il breve testo di Sciascia (l’ultimo) dal quale il film è tratto. Tutto uguale: la struttura degli eventi, l’abbozzo dei personaggi, la scansione dei tempi. Eppure c’è nella pellicola qualcosa di miracoloso, un’alchimia – paura a parte – che non mi ha più consentito di restituire a Sciascia il suo libro lasciandomelo nella memoria solo e soltanto come un film di Emidio Greco. Un miracolo, sì. Perché, detto di un’eccellente operazione di casting: il meglio delle nuove e ben scolpite facce da cinema in circolazione in Italia all’inizio degli anni Novanta (Fantaschini, Dapporto, Ghini, i due Tognazzi) con Volontè e Sperandeo a far vibrare toni ed espressioni di contrapposte sicilianità, la mano del regista non aggiunge, non incrementa, neppure dilata. Le sessanta scarne paginette della trama sono lì, sullo schermo, senza divagare. Per leggerle bastano venti muniti, il film dura un’ora e mezza.
Si potrebbe tentare di impostarla in termini matematici (come può un’addizione rigorosa dare un valore enormemente superiore alla somma degli addendi?), socio-economici (dov’è il plusvalore?), filosofico-religiosi (se nulla si crea dal nulla e se tutto si trasforma e niente si distrugge…), ma non se ne viene a capo senza ricorrere alle squilibrate leggi del cinema che consentono all’occhio del regista di estendere al limite dell’esplosione i confini di un oggetto inerte. Una storia semplice è un film quieto e manierato (che non vuole affatto dire manierista. I Coen sono manieristi; sublimi, ma manieristi. Greco è un verista metafisico) quanto quieto è manierato sa essere un vulcano. Sotto la superficie delle immagini le corde sono tese al massimo, il magma denso e incandescente, l’eruzione incombente; ogni singolo quadro è pronto a divorare la cornice. E non fa paura questo non appena te ne accorgi? Non è consapevolezza che spalanca le porte all’unico, vero panico possibile?
In Sciascia c’è un ammiccamento (gli uffici di polizia deserti, ma illuminati per trasmettere sicurezza)? Emidio Greco ce lo restituisce pari pari, senza ricamarci sopra. Né intorno. Lui ci mette una bomba sotto. L’esplosivo (il valore aggiunto alla magistrale tensione che Sciascia sa creare a dispetto della sinteticità, o forse proprio grazie ad essa) viene proprio dal non fare con le immagini la cresta al racconto; dal cucirle insieme col filo del sospetto senza che ne trapeli l’imbastitura; dal non dare all’inquietudine altro fiato che non sia la coscienza di un alito ostile; dal giocare d’abile anticipo con la macchina da presa sulle facce dei personaggi: sappiamo sempre cosa pensano (o temono, o quali pensieri abortiscono) con immediata certezza: la loro mente si travasa in noi per mezzo di una mediazione impalpabile eppure violentissima perché diretta. La scena a nervi tesi (e ghiandole, sinapsi tese) che si svolge tra commissario e brigadiere tra quelle invalicabili nel loro ufficio è esemplare del metodo: si segue un copione esiguo, si gioca a scacchi con la tensione, la si fa esplodere con rumorosità attutita, la si dilata nell’eco e non nella realizzazione, nella percezione e non nell’impatto.
Con l’ovvia eccezione del successivo Milonga (dove l’overdose di traslucida comunicazione di Una storia semplice ‘implode’ nel proprio vertice opposto: lo smarrimento nell’incomunicabilità. Che sia una storia così semplice l’anello di congiunzione tra Greco e Antonioni?) sono partito da qui, dalle gesta mafiosastre di personaggi che Sciascia lascia senza nome affinché possano averli tutti, alla scoperta del cinema di Emidio Greco. Credo che il suo ‘giallo siciliano’ faccia caso a sé, nulla a che vedere con il resto della produzione del regista. Altro stile, diverso.
Forse una deviazione, forse un’infedeltà, forse un caso di (lucidissima) incoscienza scaturito dalla possibilità di affidarsi ad un testo più docilmente maneggiabile (almeno nella struttura) di quelli di Bioy Caseres (L’invenzione di Morel) o della Blixen (Ehrengard).
La rarefazione che tanto mi è sembrata cara all’immaginario e agli strumenti di Greco, in Una storia semplice non è più vezzo, né artificio, né sofferenza, né stordimento che sembra mistero, ma diviene (con un solo passaggio: dal piano dell’atmosfera a quello del ritmo) meccanismo d’indagine e ferita di coltello. E’ un film che viaggia su rotte e su mappe crude tracciate – e spero di non aver lasciato scorrere troppe righe prima di ricordare Andrea Barbato – con il liquido inesorabile che fa crescere la coscienza dell’assurdo sempre in agguato dietro certa inzaccherata quotidianità.
E’ un film di tempi e sul tempo; un film che rifiuta con saggezza la comoda via del giallo modello Agatha Christie in versione siciliana che avrebbe sedotto altri e che Sciascia stesso abbozza (il commissario gestisce la telefonata da cui tutto parte con l’affettata disinvoltura del narratore di Dalle nove alle dieci); un film di assoluta completezza all’interno dei propri confini: finisce là dove deve finire, in una spirale di allontanamento, dopo aver esaurito la possibilità del narrare per immagini e lasciando campo a un universo di ultrasuoni.
Finisce con un ritorno a casa. Una macchina sempre più piccola, con dentro un rappresentante che canticchia dopo aver scacciato dalla testa un’idea () e la tentazione di fare il proprio (presunto) dovere. E’ successo troppo o non è successo nulla?
Una storia semplice indica una semplice via all’inconscio. Il metro per giudicare l’efficacia del cinema non è l’abilità nel mistificare il buffetto che consola, né il saper gonfiare l’azione che indigna. Da quella sera in via Hoepli, sono convinto che il termometro più preciso sia la paura.
(tratto da PENSA ALLA TUA LIBERTA\’ – IL CINEMA DI EMIDIO GRECO, Edizioni Falsopiano)